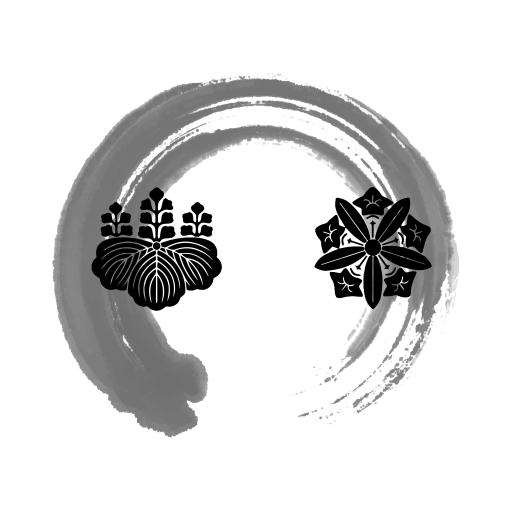Il Vesak è la principale festività buddhista: celebra la nascita, il risveglio e il parinirvāṇa del Buddha Śākyamuni. È un momento per tornare al cuore della pratica: coltivare consapevolezza, saggezza e compassione.
Il Vesak 2025 ha assunto un significato speciale per i buddhisti italiani e per l’Unione Buddhista Italiana (UBI), che quest’anno celebra il quarantesimo anniversario della sua fondazione. È stata un’occasione per rileggere la storia come incontro tra tradizioni buddhiste e cultura italiana. Il tema scelto per l’edizione 2025 è stato “La Cura”: cura degli esseri senzienti, dell’ambiente, delle parole, delle relazioni. Un invito a rendere la spiritualità una responsabilità condivisa.
A inaugurare il programma, subito dopo la conferenza di apertura, è stato l’incontro Oltre il Sé, con il Ven. Othok Rinpoche, abate del Monastero di Namgyal a Dharamsala (India), e il prof. Marcello Ghilardi, docente di Estetica all’Università di Padova. A condurre l’incontro, Stefano Davide Bettera, presidente dell’Unione Buddhista Europea. Un dialogo che ha posto al centro il tema dell’identità come relazione.
Non si trattava di un concetto astratto, ma di un invito concreto a riconsiderare il modo in cui viviamo, pensiamo e ci relazioniamo agli altri — a partire da una possibilità radicale: che l’identità non sia qualcosa da affermare, ma da attraversare.
“Il mio io non è fisso, ma aperto alla relazione”, ha affermato Ghilardi. A partire da una semplice osservazione linguistica — in giapponese esistono sei o sette modi diversi per dire “io” — si è aperta la riflessione sull’identità non come qualcosa di rigido, ma come una realtà dinamica, che si costruisce nell’incontro con l’altro. Da lì il passo verso Platone, Hegel, i Vangeli è stato breve: “Anche nel pensiero occidentale,” ha detto, “troviamo che al cuore dell’identità c’è sempre la relazione.”
“Chi perde la propria vita la guadagnerà”, disse Gesù, parlando di psyché e zoé, della vita come possesso e della vita come apertura.
Ecco il punto: la verità non è binaria. Non è: o c’è il sé o non c’è. Esiste un altro tipo di verità: quella che accoglie la contraddizione.
Nel lessico buddhista, questa tensione si esprime tra samvrtisatya (verità convenzionale) e paramarthasatya (verità ultima). La prima è quella della vita quotidiana, dei ruoli, delle regole, la realtà del semaforo rosso e della multa da pagare. La seconda è il sé relazionale, infinito, che si apre all’alterità.
“Andare oltre il sé,” ha detto Ghilardi, “significa disporsi alla cura”. Ha spiegato che il verbo latino meditor, da cui deriva “meditazione”, indica un atto di cura profonda: non per fuggire dalla realtà, ma per trasformare lo sguardo e il modo in cui ci stiamo dentro.
Il Ven. Othok Rinpoche ha tracciato una linea netta tra due visioni della felicità: quella che rincorre condizioni esterne e quella che nasce dalla mente allenata. “Più migliorano le condizioni esterne,” ha detto, “più siamo inquieti. Perché la felicità non viene da fuori. Viene dal nostro modo di pensare.”
E ha aggiunto: “La radice del Dharma è la compassione.” Non era teoria, ma invito.
“Se il nostro benessere dipende dagli altri,” ha continuato Rinpoche, “allora gli altri sono molto importanti.” E da lì ha richiamato i fondamenti del Mahayana: la bodhicitta, la mente dell’illuminazione, come pratica concreta: “Tutto ciò che di positivo sperimentiamo,” ha detto, “dipende dal prenderci cura degli altri. Tutta la sofferenza, invece, nasce dal prenderci cura solo di noi stessi.”
La compassione, nel buddhismo, non è una semplice emozione, ma un modo di guardare, di stare in relazione. È il cuore del percorso. Rinpoche ha citato i testi classici: “la radice del sentiero è la compassione, ed è importante in ogni fase — all’inizio, nel mezzo, alla fine.”
È stato Ghilardi, più avanti, a fare da ponte con la tradizione cristiana e la filosofia europea, evocando Lévinas, Spinoza, Meister Eckhart. “La relazionalità,” ha detto, “non è un di più. È originaria. Non ci sono soggetti che poi decidono di entrare in relazione. La relazione è ciò che ci rende soggetti.”
Una delle domande finali è arrivata dal pubblico: chi muore nel dolore fisico, chi muore di fame, muore da solo? Ghilardi ha risposto senza retorica: “Sì, moriamo da soli. Ma moriamo anche agli altri. E se il dolore dell’altro mi trasforma, allora quel dolore non è solo sofferenza: è apertura, è insegnamento.”
Non si tratta di negare il dolore, o estetizzarlo. “Anche oggi, con i nostri inciampi e le nostre lacrime,” ha detto Ghilardi, “si apre la possibilità della liberazione. Ogni giorno è un giorno buono. Non solo per morire, ma anche per vivere.”
L’incontro si è chiuso con un senso di possibilità: nessuna conclusione, nessun punto fermo. Solo un invito: a guardare più a fondo, a lasciarsi trasformare, a coltivare il rispetto e la cura. Perché, come ha detto Rinpoche, “Possiamo anche vivere cento anni. Ma alla fine dovremo lasciare tutto. L’unica cosa che portiamo con noi è il nostro modo di pensare. Ecco perché è importante coltivare amore e rispetto reciproco. Perché in questo modo, anche il momento del trapasso può essere sereno.”
Una chiamata alla responsabilità della relazione — dove la compassione non è sentimento, ma struttura portante. Non oltre il sé come rinuncia. Ma oltre il sé come vera libertà.
Tatiana Guarini
(Immagine tratta dalle Dieci Icone del Bue)