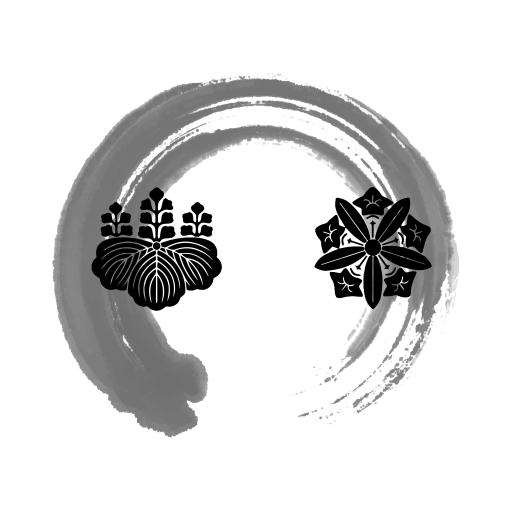Sono nato e cresciuto in Barriera di Milano, un quartiere periferico di Torino.
Il suo nome lo deve alla vicinanza con l’autostrada che conduce al capoluogo lombardo, cuore dell’immigrazione interna negli anni ’60 e attualmente interessata da quella straniera.
Un quartiere, oggi come allora, considerato difficile, dove non mancano degrado e disagio sociale, microcriminalità e droga.
Nonostante tutto ciò io mi sono sempre divertito molto, avendo la fortuna di vivere la ricchezza delle grandi borgate di confine, persone dal cuore leale, ragazzi semplici e curiosi che sono riusciti con ironia e immaginazione ad adattare i valori della tradizione famigliare d’origine a un contesto nuovo e complesso.
Ricordo in particolare una sera dei primi anni Novanta: confidavo ad un’amica di avere difficoltà a raccontare ad altri i miei problemi per timore di non essere ascoltato.
Lei sorrise amabilmente e mi consigliò di parlare comunque senza preoccuparmi di quanto si potesse coinvolgere o meno l’interlocutore, perché l’essenziale era comunque sfogarsi, e quindi lo scopo sarebbe stato raggiunto comunque.
Ancora oggi non ne sono molto convinto, però da allora migliorarono decisamente i rapporti con la persona che oggi considero il mio migliore amico, famoso per aver ascoltato amabilmente per venti minuti una ragazza che dopo qualche istante di silenzio, perché distratta da qualcos’altro, gli chiese: “Dov’ero rimasta?”, e lui con sincero stupore rispose: “E lo chiedi a me? Ti ho persa da dieci minuti!”
Ascoltare davvero non è la consuetudine, è più facile farsi attraversare dalle parole e dai nostri giudizi che si appoggiano ad esse, o dalle nostre idee, che sperano sempre di imporsi più forti di quelle altrui.
È quindi ancora più comprensibile capire quanto possa essere complesso ascoltare il silenzio, non solo come assenza di parole, ma della cessazione del rumore di fondo e del continuo brusio della nostra inafferrabile, quanto creativa attività mentale. I Maestri Zen della Tradizione ci invitano a lasciar cadere, andando sempre più in profondità, l’ascolto stesso, in modo che, come disse il Maestro Mokurai, si possa realizzare “il suono di una mano sola”.
Di certo una delle formulazioni che mi sono più care di questa speciale assenza/presenza dell’ascolto, appartiene al Maestro Daido Strumia, fondatore dell’Enkuji: a chiusura di alcune sue lezioni di Dharma raccolte nell’opera, “L’urlo del pesce”, egli scrive che, se avesse avuto la possibilità di passare alla storia, avrebbe preferito farlo per motivi ovvi, scontati, al pari de:
Il muschio sulla roccia, il muso e la coda di un vitello appena partorito, l’unghia di un rapace nel vello di un caprone, il lampo nell’occhio di una cernia appena fiocinata, il silenzio dopo un’esplosione, l’urlo del pesce sulla graticola.
Sono una sorta di koan moderni, su cui interrogarci… impareremo mai ad ascoltare l’urlo del pesce?